































Alla metà degli anni 70, alla Scuola Normale di Pisa, poteva accadere che un austero assistente di filologia classica invitasse uno o due studenti meritevoli a sedere compostamente nella Sala Musica, che disponeva come non tutti allora di un impianto hi-fi, per ascoltare fluire dal 33 giri il lungo, cangiante tessuto di strofe di Sad Eyed Lady of the Lowlands, apprezzandone parola per parola l'oscurità da ode pindarica.
I testi di Dylan erano pubblicati allora in uno spesso “paperback poeti” Newton Compton dalla copertina morbida, spesso usurata per la consultazione. Quei testi erano un thesaurus a sé, che andava confrontato, studiato e anche interpretato, non senza difficoltà, in un dibattito che ben prima dei tempi di internet attraversava i continenti e portava a congetture esegetiche a volte maniacali, come ad esempio quella sul significato (letterale o metaforico?) della “soglia” evocata in Temporary Like Achilles. Già allora il corpus di Dylan era una “scrittura” e ciò che provocava in noi denunciava la forza di un classico. Nella distinzione crociana tra poesia e non poesia, nessuno di noi allora era sfiorato dal dubbio che quella non fosse poesia. Era poesia melica, destinata, cioè, ad essere cantata.
Analizzavamo i versi di Dylan non troppo diversamente da quelli di Pindaro. Anche i greci dietro le loro poesie avevano la musica. Chissà se nella fonetica degli antichi dialetti greci, nel vocalismo del dorico o dello ionico, si avvertiva qualcosa di simile al vertiginoso artificio della voce di Dylan, a quell'estenuarsi espressionistico della parlata dell'ebreo del Minnesota nella cantilena del black American, con le vocali che si allungavano e si stringevano in una prosodia spiazzante, in una metrica stridula e singhiozzante di lunghe e brevi che la musica sosteneva, ma non creava, perché a crearla era una volontà poetica. Nella lirica monodica di Dylan, l'ebreo che cantava come un nero e faceva risuonare insieme le grida dei ghetti in fiamme e le sprezzature dell'upper class newyorchese, l'intera cultura americana partecipava coralmente. Era la sintesi di molte memorie: la cantilena del sud, dei lamenti degli schiavi, la voce ancestrale dell'Africa, da cui dipende com'è noto la melodia di Blowin'in the Wind; la tradizione dei folksinger militanti come l'amato Woody Guthrie, dei bardi erranti, dei vagabondi che percorrevano il paese dormendo sui treni e seminando le praterie di desolati blues; ma anche le antiche radici letterarie europee, che fin dal nome d'arte, scelto in omaggio a Dylan Thomas, riandavano al romanticismo di Poe, all'imagismo di Pound, al flusso di coscienza di Joyce, a Eliot, a Brecht e Weil, più volte citati, ma anche a Rimbaud e Verlaine, entrambi esplicitamente menzionati, alla visionarietà mistica di Whitman, che sfocerà in testi propriamente profetici come All Along the Watchtower (ispirato a Isaia 21, 1-12), o misterici, come Isis. Dylan era personalmente legato alla controcultura della beat generation, ma il suo approccio alla rivoluzione psichedelica attingeva di prima mano alle visioni dei grandi dionisiaci inglesi come Coleridge; e la passione per Blake è confermata dall'incisione, insieme a Allen Ginsberg, delle sue poesie musicate. In tutto questo, in quella che lui stesso ha definito un'arte “storico- tradizionale”, Dylan ha riunito la complessità abissale dell'America.
Il corpus di Dylan non è la colonna sonora del nostro tempo: i suoi testi sono preghiera, poesia liturgica, una liturgia delle ore che affiora nelle nostre vite e su cui almeno due generazioni,
di Davide Van De Sfroos
Un pomeriggio, entrò nella stanza con dei giornalini che il signor Luciano mi prestava e con sorriso compiaciuto, perché Dario Fo le aveva offerto un cappuccio. Dario Fo. Lo avevo visto qualche volta sulla terrazza dove era ospite, nella villetta confinante con quella degli zii. Non avevo capito bene chi fosse, ma raramente avevo incontrato qualcuno così simile al proprio nome. Un sorriso perpetuo e un dolcevita scuro di cotone, un mento che si ripeteva su sé stesso e che metteva di buon umore e qualcosa di profondamente divertito nei confronti di tutti e di tutto e forse della vita stessa. Nessun altro avrebbe potuto essere Dario Fo. Se mi avessero detto disegnami un Dario Fo, lo avrei fatto proprio così. Lo spiavo con curiosità: cercavo di captare qualche frase dentro la sua voce piena di sfumature insolite, studiavo la sua mimica facciale. Rimase una figura distante e misteriosa, anche se lo incrociavo in continuazione. Finì la vacanza e si tornò a casa. Negli anni a seguire, nei pochi canali tv a disposizione, capitava qualche volta di vedere quell'uomo su un palcoscenico, con la stessa maglietta e la stessa maschera di quando lo vedevo leggere il giornale al bar. Gli dedicavo tutta la mia attenzione, le prime volte perché era quello che aveva bevuto il caffè con mia mamma, ma poi perché qualcosa di lui mi ipnotizzava e soprattutto mi penetrava e mi tirava come un cavatappi. Non avevo mai preso in considerazione il fatto che uno potesse stare lì, sotto i riflettori con un pubblico davanti e senza nemmeno un costume di scena e fare così: ridere, piangere, allungandosi e accorciandosi come una gomma da masticare, cambiando il mondo contenuto nello sguardo e anche quello circostante con un semplice tono di voce. Lo ascoltavo capendo parzialmente i sentieri ideologici e senza tener conto delle sfumature storiche, sociologiche o satiriche, ma comprendendo in pieno la forza della libertà di espressione. Si poteva parlare in lingue non convenzionali o addirittura in una mistura antropologica di esse? Si poteva aprire un sorriso per lasciare entrare ed uscire qualsiasi tematica, anche la più spietata come fosse il giullare sfuggito da un sovrano distratto? Era possibile mettere in scena qualunque cosa, anche quella che poteva sembrare la più scomoda e addirittura le vicende che ti avevano sfregiato? Dario Fo mi regalò la consapevolezza di un ipotesi che fino ad allora non avevo considerato e che si meritava un Nobel. La risposta a queste domande ha continuato a soffiare nel vento, facendo discutere e spingendo tante persone nel proprio viaggio. Certo, «la risposta soffia nel vento», ha sempre cantato Dylan, ma proprio ora che lo stesso premio di Dario Fo, il comitato Nobel lo ha assegnato a lui...credo che per un istante possiamo sentire il vento cessare e la risposta arrivare con la fragorosa risata dell'uomo con la maglietta scura.
Davide Van De Sfroos
Il Corriere della Sera
16 ottobre 2016
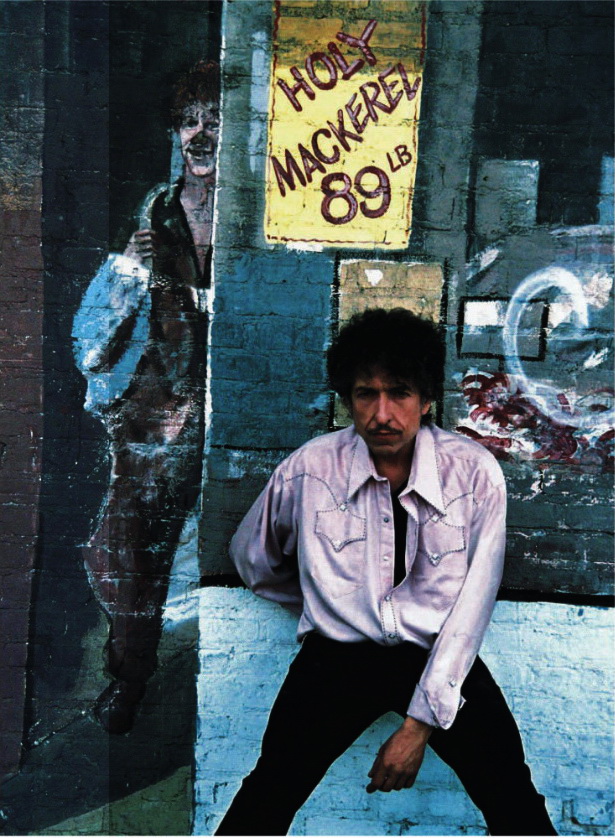

Sylvia Ronchey:
Un classico universale la sua voce è la liturgia dei nostri tempi
La Repubblica
16 ottobre 2016