



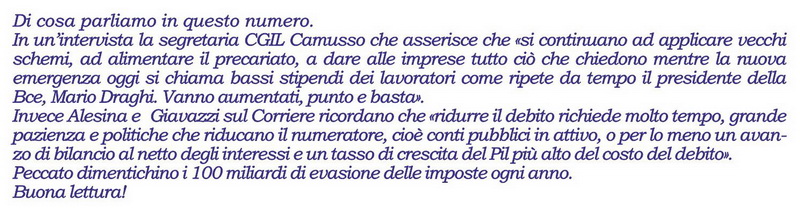




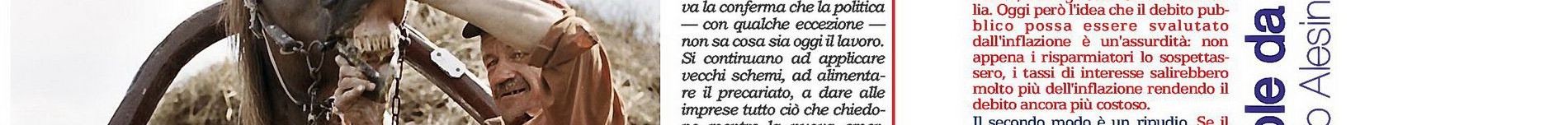
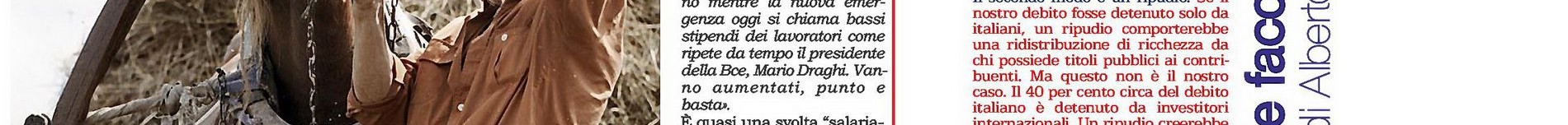
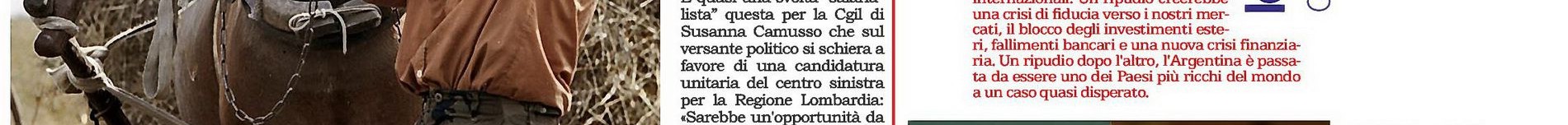
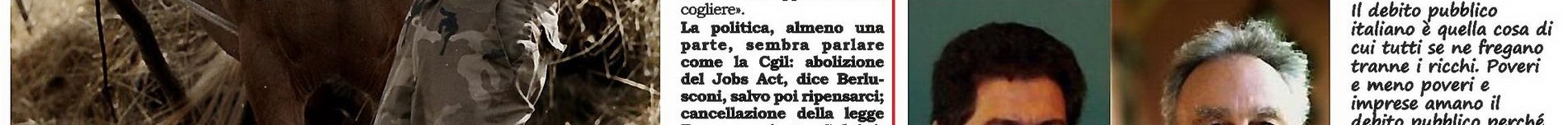
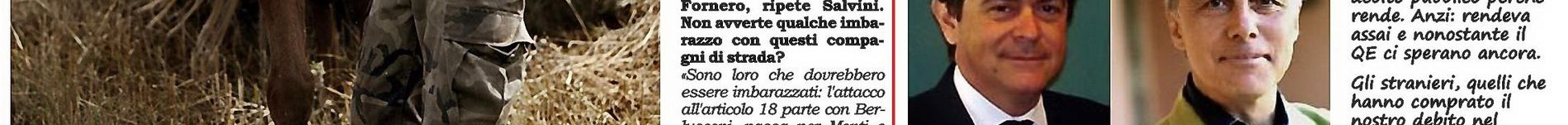
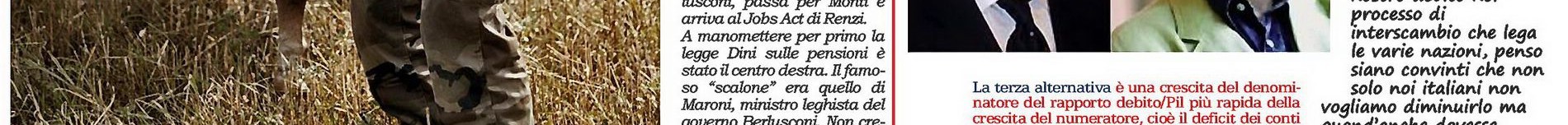
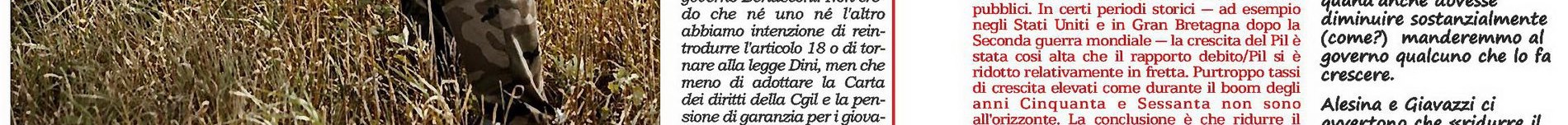
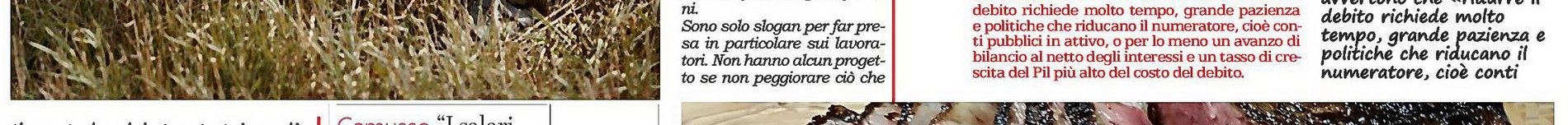



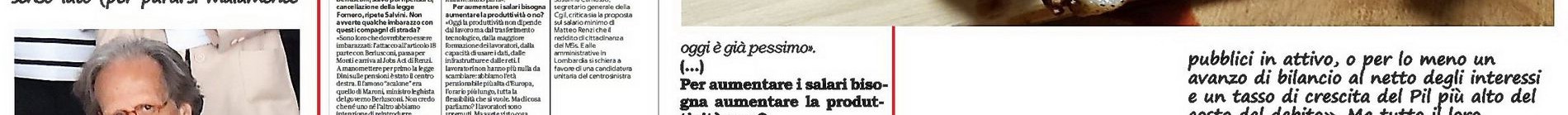
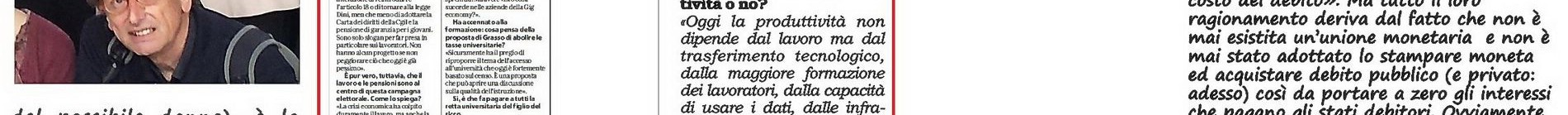

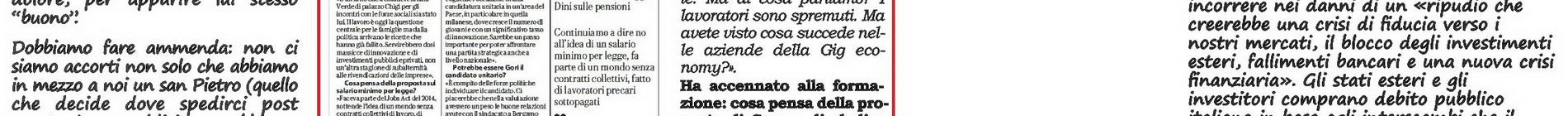
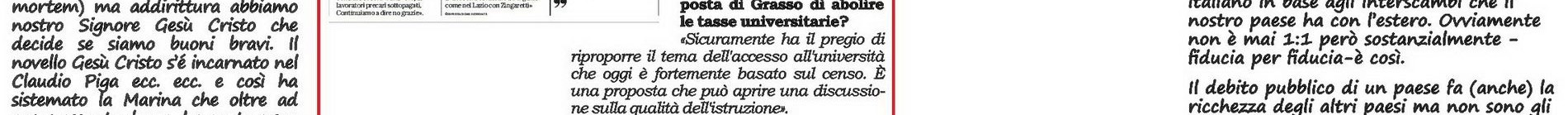
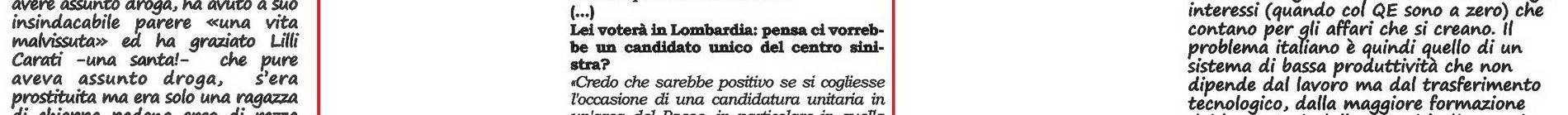
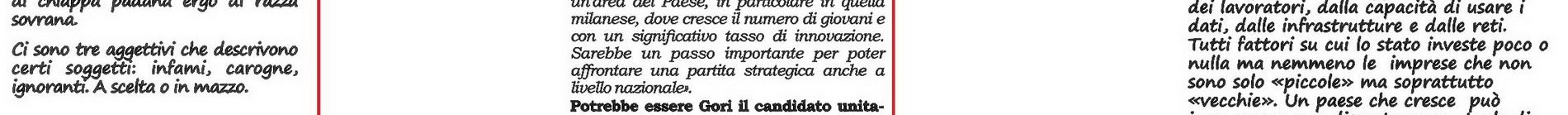
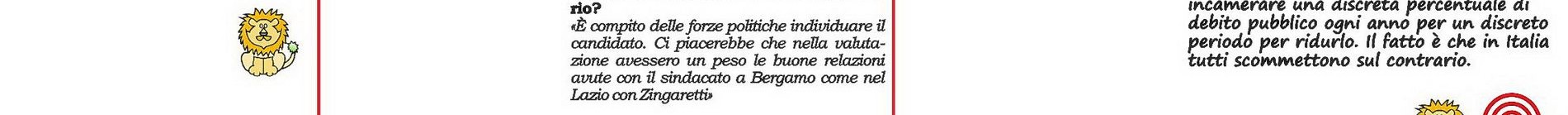


| Il
custode del La Latrina di Nusquamia tale Claudio Piga di origine
sardAgnole ma abduano di Trezza d'Adda con ascendenze garibaldine in
Valcamonica, uno che ha fatto il classico dai preti nell'ex liceo di A.
Gramsci studiando latino e greco, ingegnere laureato al Politecnico di
Milano dove ha appreso analisi matematica dalla Ajroldi Vasconi oltre a
geometria proiettiva e meccanica razionale, mentre si appresta
all’udienza col suo acerrimo contendente Pedretti sentendo la puzza che
dopo una ce ne potrebbe stare una seconda, si rivolge
furbescamente a noi: «Non meno pornografica, sempre in senso lato (per
pararsi malamente del possibile danno), è la rappresentazione del
proprio dolore, in occasione del dolore altrui: come quando per esempio
uno che solitamente è una carogna vuol mostrarsi partecipe dell'altrui
dolore, per apparire lui stesso “buono”. Dobbiamo fare ammenda: non ci siamo accorti non solo che abbiamo in mezzo a noi un san Pietro (quello che decide dove spedirci post mortem) ma addirittura abbiamo nostro Signore Gesù Cristo che decide se siamo buoni bravi. Il novello Gesù Cristo s’é incarnato nel Claudio Piga ecc. ecc. e così ha sistemato la Marina che oltre ad avere assunto droga, ha avuto a suo insindacabile parere «una vita malvissuta» ed ha graziato Lilli Carati -una santa!- che pure aveva assunto droga, s’era prostituita ma era solo una ragazza di chiappa padana ergo di razza sovrana. Ci sono tre aggettivi che descrivono certi soggetti: infami, carogne, ignoranti. A scelta o in mazzo. |
“I salari vanno
aumentati Gori un’opportunità per il Pd e Grasso” ROBERTO MANIA, ROMA «Dalla proposta
del salario minimo legale a quella sul reddito di cittadinanza arriva la
conferma che la politica — con qualche eccezione — non sa cosa sia oggi il
lavoro. Si continuano ad applicare vecchi schemi, ad alimentare il precariato,
a dare alle imprese tutto ciò che chiedono mentre la nuova emergenza oggi si
chiama bassi stipendi dei lavoratori come ripete da tempo il presidente della
Bce, Mario Draghi. Vanno aumentati, punto e basta». È quasi una svolta
“salarialista” questa per la Cgil di Susanna Camusso che sul versante politico
si schiera a favore di una candidatura unitaria del centro sinistra per la
Regione Lombardia: «Sarebbe un’opportunità da cogliere». La politica,
almeno una parte, sembra parlare come la Cgil: abolizione del Jobs Act, dice
Berlusconi, salvo poi ripensarci; cancellazione della legge Fornero, ripete
Salvini. Non avverte qualche imbarazzo con questi compagni di strada? «Sono loro che
dovrebbero essere imbarazzati: l’attacco all’articolo 18 parte con Berlusconi,
passa per Monti e arriva al Jobs Act di Renzi. A manomettere
per primo la legge Dini sulle pensioni è stato il centro destra. Il famoso
“scalone” era quello di Maroni, ministro leghista del governo Berlusconi. Non
credo che né uno né l’altro abbiamo intenzione di reintrodurre l’articolo 18 o
di tornare alla legge Dini, men che meno di adottare la Carta dei diritti della
Cgil e la pensione di garanzia per i giovani. Sono solo
slogan per far presa in particolare sui lavoratori. Non hanno alcun progetto se
non peggiorare ciò che oggi è già pessimo». È pur vero,
tuttavia, che il lavoro e le pensioni sono al centro di questa campagna
elettorale. Come lo spiega? «La crisi
economica ha colpito duramente il lavoro, ma anche la dimostrazione che le
brutte leggi di questi anni non hanno fatto altro che peggiorare le condizioni,
soprattutto per i giovani. Penso, poi, sia merito dei sindacati, e della Cgil
in particolare, aver riproposto il tema della centralità del lavoro e della sua
rappresentanza. Mi pare la più evidente sconfitta di tutti coloro che avevano
immaginato il superamento dei corpi intermedi, che il lavoro non avesse più
bisogno di soggetti di rappresentanza». Anche questa
colpa di Renzi? «È un fatto che
a chiudere la Sala Verde di palazzo Chigi per gli incontri con le forze sociali
sia stato lui. Il lavoro è oggi la questione centrale per le famiglie ma dalla
politica arrivano le ricette che hanno già fallito. Servirebbero dosi massicce
di innovazione e di investimenti pubblici e privati, non un’altra stagione di
subalternità alle rivendicazioni delle imprese». Cosa pensa della
proposta sul salario minimo per legge? «Faceva parte
del Jobs Act del 2014, sottende l’idea di un mondo senza contratti collettivi
di lavoro, di lavoratori precari sottopagati. Continuiamo a
dire no grazie». Il ministro
Poletti dice che legge e contratti possono coesistere. «Furberie: è un
modo per far venire meno il vincolo contrattuale per le imprese. È la fine dei
contratti collettivi nazionali per affidare al sindacato il solo compito di
occuparsi delle ristrutturazioni aziendali. È una ricetta che non può
funzionare. Ho il dubbio che davvero non conoscano il lavoro». C’è il dubbio
che anche il sindacato non abbia fatto fino in fondo il suo mestiere se i
lavoratori italiani sono nelle condizioni che descrive lei. «Riconosco che
siamo arrivati in ritardo a capire la diffusione e il radicamento del lavoro
precario. Ma ci abbiamo
messo dieci anni per rinnovare i contratti pubblici, per responsabilità della
politica, e per farlo nel privato è stato faticosissimo. C’è una questione
salariale di cui, a parte la Bce, in Italia nessuno parla». Per aumentare i
salari bisogna aumentare la produttività o no? «Oggi la
produttività non dipende dal lavoro ma dal trasferimento tecnologico, dalla
maggiore formazione dei lavoratori, dalla capacità di usare i dati, dalle
infrastrutture e dalle reti. I lavoratori non hanno più nulla da scambiare:
abbiamo l’età pensionabile più alta d’Europa, l’orario più lungo, tutta la
flessibilità che si vuole. Ma di cosa parliamo? I lavoratori sono spremuti. Ma
avete visto cosa succede nelle aziende della Gig economy?». Ha accennato
alla formazione: cosa pensa della proposta di Grasso di abolire le tasse
universitarie? «Sicuramente ha
il pregio di riproporre il tema dell’accesso all’università che oggi è
fortemente basato sul censo. È una proposta che può aprire una discussione
sulla qualità dell’istruzione». Sì, è che fa
pagare a tutti la retta universitaria del figlio del ricco. «Questa
obiezione vale anche per la scuola dell’obbligo». Ma è appunto la
scuola dell’obbligo. «Se ci fosse reale
progressività nel sistema fiscale questo problema non si porrebbe». Lei per chi
voterà? «Non lo dico». Comunque voterà
in Lombardia: pensa ci vorrebbe un candidato unico del centro sinistra? «Credo che
sarebbe positivo se si cogliesse l’occasione di una candidatura unitaria in
un’area del Paese, in particolare in quella milanese, dove cresce il numero di
giovani e con un significativo tasso di innovazione. Sarebbe un passo
importante per poter affrontare una partita strategica anche a livello nazionale». Potrebbe essere
Gori il candidato unitario? «È compito
delle forze politiche individuare il candidato. Ci piacerebbe che nella
valutazione avessero un peso le buone relazioni avute con il sindacato a
Bergamo come nel Lazio con Zingaretti» |
PIANI ELETTORALI le favole da evitare
sul debito di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi Luigi Di Maio ha consegnato alla stampa un suo scritto in cui annuncia che
il Movimento 5 Stelle sta elaborando un piano per ridurre in due legislature il
debito pubblico del 40 per cento del Pil, da 130 circa, il livello di oggi, a
90. Il piano non comporterebbe tagli alla spesa pubblica, anzi dovrebbe
prevedere un aumento della spesa per infrastrutture. Abolirebbe anche la
riforma pensionistica (la legge Fornero), un provvedimento che la Ragioneria
generale dello Stato stima produrrà, nel biennio 2019-20, un risparmio di 25
miliardi l’anno lordi (cioè senza tener conto dell’effetto sulle imposte pagate
dai pensionati). Queste favole fiscali sono solo leggermente meno fantasiose delle promesse
di Donald Trump (al quale Di Maio evidentemente si ispira), quando in campagna
elettorale annunciava che avrebbe annullato il debito pubblico americano in 8
anni (due legislature appunto) aumentando, anche lui, le spese per
infrastrutture e riducendo le imposte. Di Maio (proprio come Trump) non ci dice come intenda realizzare questa
straordinaria riduzione del debito. Trenta-quaranta punti di taglio sul Pil in
10 anni non sono impossibili ma richiedono almeno un paio di cose: dei surplus
di bilancio notevoli (altro che aumenti di spese e abolizione della legge
Fornero!), e dei tassi di interesse reali che rimangano assai bassi, e questo
non dipende da noi. La storia e la teoria
economica ci spiegano che per ridurre il debito ci sono tre modi. Il primo è svalutare
il valore reale del debito con una «botta di inflazione». L’iperinflazione
tedesca degli anni 20 cancellò l’enorme debito pubblico che la Germania aveva
accumulato durante la Prima guerra mondiale, contribuendo a provocare eventi
sociali e politici drammatici. Anche dopo la Seconda guerra mondiale
l’inflazione svalutò, seppure in modo meno drammatico, il valore reale del
debito, sia negli Stati Uniti che in Italia. Oggi però l’idea che il debito
pubblico possa essere svalutato dall’inflazione è un’assurdità: non appena i
risparmiatori lo sospettassero, i tassi di interesse salirebbero molto più
dell’inflazione rendendo il debito ancora più costoso. Il secondo modo è un
ripudio. Se il nostro debito fosse detenuto solo da italiani, un ripudio
comporterebbe una ridistribuzione di ricchezza da chi possiede titoli pubblici
ai contribuenti. Ma questo non è il nostro caso. Il 40 per cento circa del
debito italiano è detenuto da investitori internazionali. Un ripudio creerebbe
una crisi di fiducia verso i nostri mercati, il blocco degli investimenti
esteri, fallimenti bancari e una nuova crisi finanziaria. Un ripudio dopo
l’altro, l’Argentina è passata da essere uno dei Paesi più ricchi del mondo a
un caso quasi disperato. La terza alternativa è una crescita del
denominatore del rapporto debito/Pil più rapida della crescita del numeratore,
cioè il deficit dei conti pubblici. In certi periodi storici — ad esempio negli
Stati Uniti e in Gran Bretagna dopo la Seconda guerra mondiale — la crescita
del Pil è stata cosi alta che il rapporto debito/Pil si è ridotto relativamente
in fretta. Purtroppo tassi di crescita elevati come durante il boom degli anni
Cinquanta e Sessanta non sono all’orizzonte. La conclusione è che ridurre il
debito richiede molto tempo, grande pazienza e politiche che riducano il
numeratore, cioè conti pubblici in attivo, o per lo meno un avanzo di bilancio
al netto degli interessi e un tasso di crescita del Pil più alto del costo del
debito. Un avanzo nel bilancio pubblico si può ottenere o riducendo le spese o
aumentando le imposte. L’evidenza empirica dimostra che un aumento della
pressione fiscale su famiglie e imprese riduce la crescita, così tanto che alla
fine il rapporto debito/Pil anziché diminuire sale ancor di più. Invece, tagli
alla spesa pubblica hanno l’effetto desiderato, cioè riducono il rapporto
debito/Pil perché non rallentano la crescita, o al massimo la influenzano di
poco e per poco tempo. Questo è vero soprattutto per quelle riforme che
bloccano l’aumento automatico di certe spese come le pensioni, soprattutto
quando diventano incompatibili con l’allungamento della vita e il calo della
natalità. È per questo motivo che cancellare la legge Fornero renderebbe ancor
più difficile ridurre il debito. |
Il
debito pubblico italiano è quella cosa di cui tutti se ne fregano
tranne i ricchi. Poveri e meno poveri e imprese amano il debito
pubblico perché rende. Anzi: rendeva assai e nonostante il QE ci
sperano ancora. Gli stranieri, quelli che hanno comprato il nostro debito nel processo di interscambio che lega le varie nazioni, penso siano convinti che non solo noi italiani non vogliamo diminuirlo ma quand’anche dovesse diminuire sostanzialmente (come?) manderemmo al governo qualcuno che lo fa crescere. Alesina e Giavazzi ci avvertono che «ridurre il debito richiede molto tempo, grande pazienza e politiche che riducano il numeratore, cioè conti pubblici in attivo, o per lo meno un avanzo di bilancio al netto degli interessi e un tasso di crescita del Pil più alto del costo del debito». Ma tutto il loro ragionamento deriva dal fatto che non è mai esistita un’unione monetaria e non è mai stato adottato lo stampare moneta ed acquistare debito pubblico (e privato: adesso) così da portare a zero gli interessi che pagano gli stati debitori. Ovviamente non su tutto il loro debito. Ma è proprio negli anni in cui il QE riduce (a zero) gli interessi sul debito pubblico che se ne può azzerare gran parte -una sorta di patrimoniale- senza incorrere nei danni di un «ripudio che creerebbe una crisi di fiducia verso i nostri mercati, il blocco degli investimenti esteri, fallimenti bancari e una nuova crisi finanziaria». Gli stati esteri e gli investitori comprano debito pubblico italiano in base agli interscambi che il nostro paese ha con l’estero. Ovviamente non è mai 1:1 però sostanzialmente -fiducia per fiducia-è così. Il debito pubblico di un paese fa (anche) la ricchezza degli altri paesi ma non sono gli interessi (quando col QE sono a zero) che contano per gli affari che si creano. Il problema italiano è quindi quello di un sistema di bassa produttività che non dipende dal lavoro ma dal trasferimento tecnologico, dalla maggiore formazione dei lavoratori, dalla capacità di usare i dati, dalle infrastrutture e dalle reti. Tutti fattori su cui lo stato investe poco o nulla ma nemmeno le imprese che non sono solo «piccole» ma soprattutto «vecchie». Un paese che cresce può incamerare una discreta percentuale di debito pubblico ogni anno per un discreto periodo per ridurlo. Il fatto è che in Italia tutti scommettono sul contrario. |